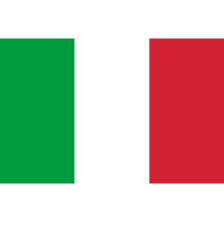(Clicca sull'immagine per visualizzarla a tutto schermo)
Questo manoscritto è senza dubbio uno dei più importanti cimeli del Museo. La partitura pervenne nel 1862 al Liceo Filarmonico per lascito del professor Rinaldo Bajetti, mentre la Cenerentola andò invece all’Accademia Filarmonica, dov’è ancora custodita. Osservate bene le pagine e confrontatele, ad esempio, con gli abbozzi autografi del compositore Ponchielli – esposti nella vetrina di fronte – per la composizione de La Gioconda. La partitura del Barbiere è incredibilmente pulita, senza cancellature, né correzioni o ripensamenti, nonostante l’opera sia stata composta in poco più di quindici giorni. Ciò è dovuto, senza dubbio, alla genialità di Rossini, ma parzialmente anche al fatto che alcune parti sono veri e propri auto-imprestiti presi integralmente da opere scritte precedentemente: un esempio su tutti la celeberrima Ouverture, che nel manoscritto manca del tutto proprio perché la musica è la stessa dell’Aureliano in Palmira, esposto per questo motivo nel cassetto sotto al manoscritto (in realtà la stessa musica era già stata “riciclata” anche in occasione della messa in scena di Elisabetta Regina d’Inghilterra...).
È interessante notare che il vero titolo dell’opera, come riportato sul manoscritto, è Almaviva, o sia l’inutile precauzione, in segno di deferenza e rispetto nei confronti del Barbiere di Siviglia del celebre Paisiello, come lo stesso libretto originale spiega in un "avvertimento al pubblico". Ciò non fu sufficiente a placare i sostenitori di Paisiello, che resero la prima rappresentazione a Roma del capolavoro rossiniano un vero fiasco, fischiando e opponendosi ostilmente. Tuttavia la verve comica del Barbiere di Rossini, e l’energia travolgente che investe gli spettatori, resero l’opera un vero successo già dalla seconda recita, oscurando in breve tempo il precedente del maestro napoletano e divenendo la più celebre dell’intero catalogo rossiniano.
Torna in sala 7 per altre storie.