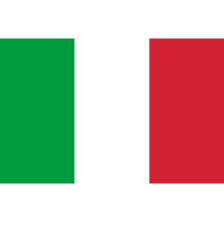"Caro Tadolini, un raffreddore m'obbliga a restare in casa. Vi prego di domandare alla Grisi definitivamente se viene dopodomani" (L. Lablache) (Clicca sull'immagine per visualizzarla a tutto schermo)
Nel corso dell’Ottocento, sebbene il melodramma assista ad una progressiva differenziazione geografica di generi e stile (a cominciare dai libretti che adottano di preferenza le singole lingue nazionali) gli operisti italiani continuano tuttavia a conservare un sostanziale primato, conquistando una ad una le capitali europee della musica (Milano, Parigi, Vienna, Londra). Ma al centro del sistema operistico non sono ancora i compositori, ma i cantanti: basti pensare che per il Barbiere di Siviglia Gioachino Rossini ottiene un compenso di 400 scudi, mentre il tenore Manuel Garcìa – un vero e proprio divo – si aggiudica come interprete una cifra tre volte superiore.
Ai cantanti, e soprattutto alle primedonne, si tessono dunque elogi in versi, stampati su fogli volanti o in calce a litografie che ritraggono l’artista in plastiche pose di scena. Isabella Colbran, cantante prediletta da Rossini e poi sua prima moglie, Giuditta Pasta, interprete fondamentale per compositori come Donizetti e Bellini, Maria Malibran (figlia di Garcìa) celebrata come la più commovente interprete di tutti i tempi già prima che la morte prematura giungesse a consacrarne definitivamente il mito, sono tra le primedonne più amate e acclamate d’inizio Ottocento.
Giusto per fare un esempio, ecco alcuni versi fra quelli esposti:
Caro dono del Cielo è la bellezza,
Che tutte l’alme co’ suoi vezzi lega:
Virtute ha tal valore
Che soggioga ogni core.
Or, se così bei pregi
Son tutti in Te raccolti
Chi sarà che ti ascolti
E che Te Diva del canto non chiami?
Chi sarà che ti vegga, e che non t’ami?
Le quattro lettere all’impresario bolgonese Tadolini, scritte in momenti diversi da Giulia Grisi, Giovan Battista Rubini, Antonio Tamburini e Luigi Lablache – il favoloso “quartetto” stellare della prima rappresentazione dei Puritani di Bellini al Théatre Italien di Parigi (1835) – ci restituiscono una forte immagine del divismo imperante dei cantanti: i tre uomini annunciano un improvviso raffreddamento che impedisce loro di partecipare alle dovute prove dello spettacolo, mentre la primadonna pretende un’aria ad personam.
Non è difficile immaginare il sospiro di sollievo che Tadolini tirò conclusa questa monumentale produzione… e forse proprio le regole dell’ambiente operistico sono state uno dei motivi per cui, rientrato da Parigi a Bologna, Tadolini smetterà di fare l’impresario per concludere la propria vita come maestro di cappella in cattedrale.
Torna in sala 7 per altre storie!