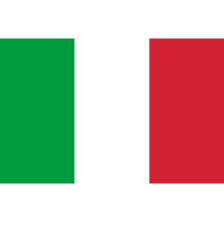Collocazione: P.124(6) (Olim Cod. 031:04)
Riproduzioni
 Digitale:
Digitale:
 Microfilm n.:
1772
Microfilm n.:
1772
Al Molto Illustre Signor Piero Falconieri mio Sig.
Hanno costumato spesse uolte coloro che appresero qualche arte, ò disciplina da alcuno, o che da alcuno ebbero occasione di apprenderla, di offrirle le prime fatiche che intorno à cotal arte o disciplina hanno fatte e mandato fuori, mostrando per questa maniera in uerso di quello alcun segno di debita gratitudine; ma riguardando io quanto grande sia l'antico obligo che io tengo alla memoria del Sig.r Paolo Falconieri che mi consigliò in mia giouentù à gli studi della musica, e mi spinse e mi sforzò, ò per dir così con l'aiuto de' suoi fauori e della sua protezzione ad impiegarmiui lungamente, offerirò A V. S. suo maggior fìgliolo non le primizie, ma quelle considerazioni che ho messo insieme intorno al modo del ben cantare da potersi apprendere ogni sua squisitezza dà gli scritti dopo l' osseruazione di molt' anni non solamente con l'esercitar continuamente nel canto me stesso, e la mia moglie, e le mie figliole, ma con l' hauer sentito i maggior cantanti huomini e donne che in Italia e fuori d'Italia sono stati nel termine di cinquant'anni, ò sono al presente. Potrà V. S. conoscere, che l' ossequio mio in uerso la casa sua cominciato ne gli anni della mia fanciullezza, è peruenuto sino a quelli della vecchiaia per far il medesimo sino al fine di quei pochi che mi possono auanzare; desiderando intanto à V. S. somma felicità e baciandole le mani.
Di Casa. il dì 18. d' Agosto 1614.
Di V. S. Molto. Ill.re Seruitore Affe.mo et Obbli .mo GIULIO CACCINI di Roma.
A DESCRITTI LETTORI « Molti anni auanti che io mettessi alcuna delle mie opere di Musica per una uoce sola alla stampa, se ne eran uedute fuora molte altre mie fatte in diuersi tempi et occasioni, delle quali furono più note la musica che io feci nella fauola della Dafne del Sig.r Ottavio Rinuccini, rappresentata in Casa del Sig.r Jacopo Corsi d' onorata memoria à quest'Altezze Serenissime et altri Pren cipi; ma le prime che io stampassi furon la musiche fatte l' anno 1600, nella fauola dell' Euridice, opera del medesimo autore, e furon le prime che si uedesser date in luce in Italia da qualunque compositore di tale stile à una uoce sola; diedi appresso fuore l' anno 1601 quelle che io intitolai le nuoue musiche, e con quelle pubblicai un discorso nel quale si contiene (s'io non erro) tutto quello che può desiderare chi professi di cantar solo. E ueduto al presente quanto l' uniuersale abbracci e gradisca questa mia maniera di cantar solo, la quale io scriuo giustamente come si canta, quanto sia preferito à gli altri, per lo spaccio che di tal' opre hanno hauuto gli stampatori; e considerato quanto, oltre al cantar solo, sia stata gradita la maniera delle musiche de' cori di dette fauole, e l' inuentione di essi, e d' altre fauole fatte poi, doue parimente ho fatto diuerse arie, secondo che richiedevano i diuersi affetti di tali cori, chiare et armoniose, mi son resoluto à stampar di nuovo quest' altre mie, alcune delle quali sono scritte nell'istessa maniera che conuiene che siano cantate, hauendo segnato sopra la parte che canta e trilli, e gruppi, et altri nuoui affetti non più ueduti per le stampe, con passaggi più proprii per la uoce, ne i quali passaggi per hora non hò uoluto mostrare altre uarietà in essi, essendomi questi parsi à bastanza per uero esercizio in quest' arte, non hauendo hauuto riguardo à replicar più uolte i medesimi, potendo esser questi scala ad altri più difficili, come ad altro tempo si mostrerà, alcune ce n' hò inserte, le quali tal' hora cantano in uoce di tenore, e tal' ora di basso con passaggi più propri per amendue le parti, e queste per uso di chi auesse talento dalla natura di ricercare gli estremi di esse uoci, essendo necessario in detta parte di basso nelle simiminime e crome col punto che discendano per grado, trillarne or l' una et hora l'altra, per darle maggior grazia, forza, e spirito, e per tirsi brauura e ardire, che più si ricerca in detta parte e nella quale ui si richiede assai meno l' effetto, che nella parte del tenore, in quanto alla misura, ò larghezza da osseruarsi in dette arie secondo che è maggiore la grauità da usarsi, conforme à gli affetti delle parole, e altri mouimenti della uoce più nell' una che nell' altra parte, io me ne rimetto al giudizio del cantante, et insieme al mio stampato discorsò del 1601. Hò segnato sopra il Basso da sonarsi e terze e seste maggiori e minori indifferentemente tanto per B. quadro, quanto per B. molle, et ogni altra cosa più necessaria, per rendermi più facile à li manco periti che auessero gusto di esercitarsi in esse. riceuetele cortesi lettori con quello affetto che io ue le porgo, e uiueti felici ».
ALCUNI AUUERTIMENTI
« Tre cose principalmente si conuengon sapere da Chi professa di ben cantar con affetto solo. Ciò sono lo affetto, la uarietà di quello, e la spezzatura. Lo affetto in Chi canta altro non è che per la forza di diuerse note, e di uari accenti co 'l temperamento del piano e del forte, una espressione delle parole e del concetto che si prendono à cantare atta à muouere affetto in chi ascolta. La uarietà nell' affetto è quel trapasso che si fà da uno affetto in un' altro co' medesimi mezzi, secondo che le parole e 'l concetto guidano il cantante successiuamente; e questa è da osseruarsi minutamente acciocche con la medesima veste (per dir cosi) uno non togliesse à rappresentare lo sposo, e il vedouo. La spezzatura quella leggiadria la quale si dà al canto co 'l trascorso di più crome e semicrome sopra diuerse corde, col quale, fatto à tempo, togliendosi al canto una certa terminata angustia e sechezza, si rende piaceuole, licenzioso, e arioso, siccome nel parlar comme la eloquenza e la fecondia rende ageuoli e dolci le cose di cui si fauella. Nella quale eloquenza alle figure, e i colori retorici assimigliarasi i passaggi, i trilli, e gli altri simili ornamenti che sparsamente in ogni affetto si possono tall'ora introdurre. Conosciutesi queste cose, crederò con l' osseruazione di questi miei componimenti, che chi aura dispositione al cantare, potrà per auuentura sortir quel fine che si desidera nel Canto specialmente, che è il dilettare. Fine. ».
Nomi: Caccini, Giulio [detto Romano].
Riferimenti bibliografici
Catalogo della Biblioteca del Liceo Musicale di Bologna: III, p. 294Antiche collocazioni: 0504 (catalogo Sarti, circa 1840)
ID: 9038 Segnalazioni (errori nella scheda, suggerimenti bibliografici ecc.)
Teoria musicale
Musica vocale sacra
Musica vocale profana
Musica strumentale
Libretti